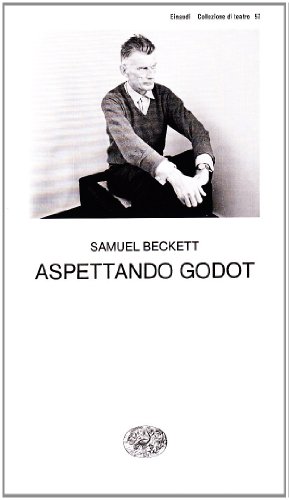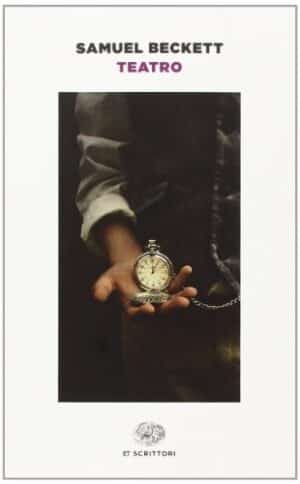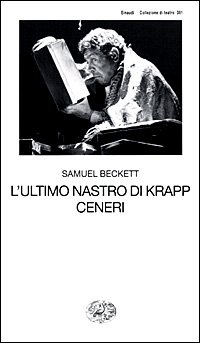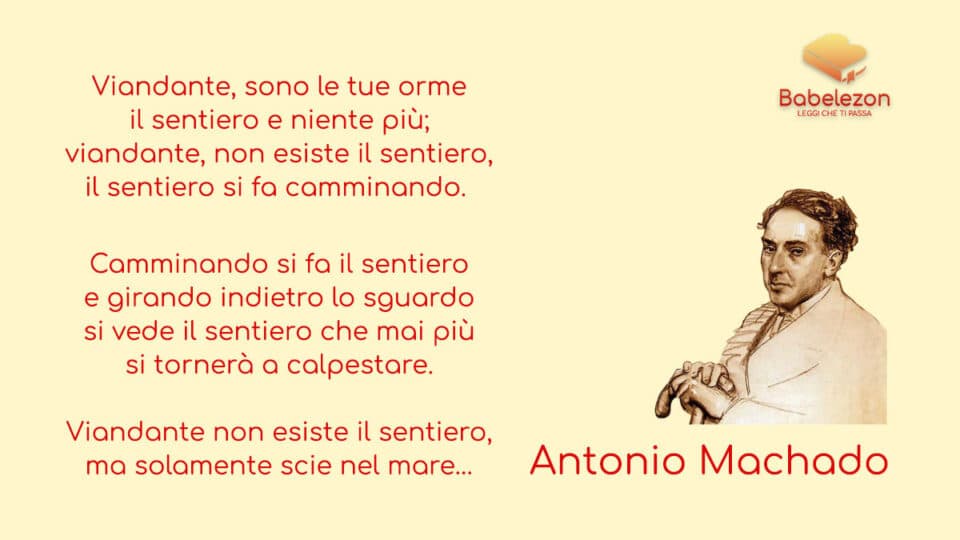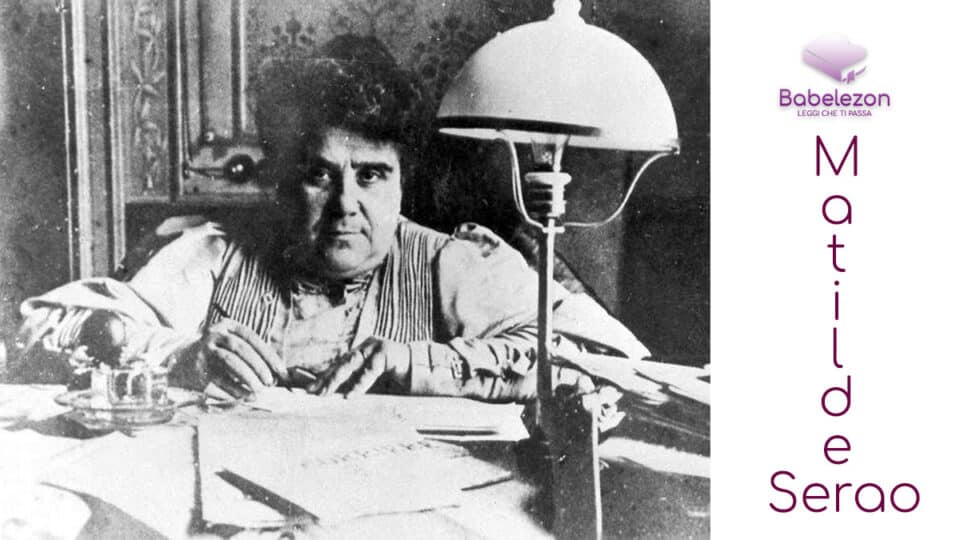La ricerca letteraria del giorno 22 dicembre: Samuel Beckett

La ricerca letteraria del giorno 22 dicembre: Helen Beatrix Potter
22 Dicembre 2023
Felicia Kingsley, la più letta in Italia nel 2023
22 Dicembre 2023
La ricerca del giorno su #babelezon
22 dicembre:  Samuel Beckett
Samuel Beckett 
Il 22 dicembre del 1989 moriva a Parigi Samuel Beckett, considerato una delle personalità più originali del secolo scorso.
E’ stato un drammaturgo, scrittore, poeta, traduttore e sceneggiatore irlandese.
Beckett, considerato uno dei più influenti scrittori del XX secolo, è universalmente riconosciuto come la figura più significativa, insieme ad Eugène Ionesco, Arthur Adamov e al primo Harold Pinter, del genere teatrale e filosofico noto come Teatro dell’assurdo, così definito da Martin Esslin. Il suo capolavoro è “Aspettando Godot”. Tuttavia, la sua produzione artistica va ben oltre il teatro, includendo opere complesse nel campo della radio, della televisione e del cinema (tra cui il film del 1965 con Buster Keaton).
Beckett è stato autore di romanzi e poesie e nel 1969 ha ricevuto il Premio Nobel per la letteratura, riconosciuto per la sua scrittura innovativa che, attraverso nuove forme di romanzo e dramma, raggiunge una grande profondità nell’esplorazione dell’abbandono dell’uomo moderno.
Nato il 13 aprile 1906 a Foxrock, un piccolo centro vicino a Dublino, studiò alla Portora Royal School, dove aveva studiato anche Oscar Wilde, e in seguito al Trinity College di Dublino. Fin da adolescente mostra i segni di un’interiorità esasperata, segnata da una ricerca ossessiva della solitudine, poi evidenziata così bene nel primo romanzo-capolavoro dello scrittore, l’allucinato “Murphy“. Non è da credere, ad ogni modo, che Beckett sia stato un pessimo studente: tutt’altro. Inoltre, contrariamente a quanto si possa pensare di un intellettuale (sebbene in erba), è molto portato per gli sport in genere, nei quali eccelle. Si dedica quindi intensivamente alla pratica sportiva, almeno negli anni del college ma, contemporaneamente, non trascura lo studio di Dante, che approfondisce ossessivamente fino a diventarne un vero esperto (cosa assai rara in area anglosassone).
Ma il profondo malessere interiore lo scava inesorabilmente e senza pietà. E’ ipersensibile e ipercritico, non solo verso gli altri, ma anche e soprattutto verso se stesso. Sono i segni riconoscibili di un disagio che lo accompagnerà per tutta la vita. Comincia ad isolarsi sempre di più, fino a condurre una vita da vero eremita, per quanto è possibile in una società moderna. Non esce, si chiude in casa e “snobba” completamente chi lo circonda. Probabilmente, si tratta di una sindrome che oggi chiameremmo, con linguaggio smaliziato e forgiato dalla psicoanalisi “depressione”. Questo male corrosivo lo costringe a letto giornate intere: spesso, infatti, non riesce ad alzarsi fino a pomeriggio inoltrato, tanto si sente minacciato e vulnerabile rispetto alla realtà esterna. Durante questo aspro periodo, il suo amore per la letteratura e per la poesia cresce sempre di più.
Si laureò in Letterature Moderne (francese e italiano) nel 1928 e, dopo aver insegnato per un breve periodo al Campbell College di Belfast si trasferì a Parigi che ha subito effetti positivi su di lui: non passa molto tempo perché il ragazzo veda nella nuova città una sorta di sua seconda patria. A Parigi ebbe l’incarico di lettore d’inglese presso l’École Normale Supérieure. A Parigi incontrò James Joyce, che aveva raggiunto una certa notorietà come il più importante autore modernista inglese, con cui strinse un’amicizia duratura.
Un altro approdo importante è la scoperta che, in qualche modo, l’esercizio della scrittura ha un effetto benefico sul suo stato, riuscendo a distrarlo dai pensieri ossessivi e fornendo un canale creativo in cui sfogare la sua sensibilità accesa, nonché la fervida immaginazione. In pochi anni, grazie ai ritmi intensi di lavoro a cui si sottopone, e soprattutto all’intuito sorvegliatissimo con cui tratta i testi, si afferma come importante scrittore emergente. Vince un premio letterario per un poema intitolato “Whoroscope”, incentrato sul tema della transitorietà della vita. Comincia contemporaneamente uno studio su Proust, autore amatissimo. La riflessione sullo scrittore francese (sfociato poi in un celebre saggio), lo illuminano circa la realtà della vita e dell’esistenza, giungendo alla conclusione che la routine e l’abitudine, “non sono che il cancro del tempo”. Un’improvvisa consapevolezza che gli permetterà di imprimere una svolta decisiva alla sua vita.
Quando suo padre morì nel 1933, questi gli lasciò una piccola eredità che gli permise di viaggiare in vari paesi europei, andò a Londra, in Francia, in Italia e in Germania e dopo qualche anno precisamente nel 1937 Beckett decise di trasferirsi stabilmente in Francia. Qui conosce Suzanne Dechevaux-Dumesnil, una donna di diversi anni più vecchia che diventa la sua amante e solo svariati anni più tardi la moglie. Parallelamente agli sconvolgimenti più o meno transitori che contrassegnano la sua vita privata, non mancano quelli generati dalla macchina della Storia, che poco si cura degli individui. Scoppia dunque la seconda guerra mondiale e Beckett opta per l’interventismo, prendendo attivamente parte al conflitto e offrendosi come esperto traduttore per le frange della resistenza. Presto, però, è costretto ad allontanarsi per evitare il pericolo che incombe sulla città e si trasferisce in campagna con Suzanne. Nel 1945 ritornò in Irlanda per visitare la famiglia, lavorò come volontario per la Croce Rossa Irlandese e fu inviato come interprete in Francia presso un ospedale militare, finita la guerra, torna a Parigi dove trova ad attenderlo consistenti difficoltà economiche.
Nel periodo fra il ’45 e il ’50 compone varie opere, tra cui le novelle “Malloy“, “Malone muore“, “L’innominabile“, “Mercier et Camier“, e alcune opere teatrali, di fatto una novità nel suo catalogo.
Sono le stesse, in pratica, che gli hanno donato fama imperitura e per cui è noto anche al grande pubblico. Vi compare, ad esempio, la celebre pièce “Aspettando Godot“, da più parti acclamata come il suo capolavoro. E’ l’inaugurazione, negli stessi anni in cui opera Ionesco (altro esponente di spicco di questo “genere”), del teatro cosiddetto dell’assurdo.
L’opera, infatti, vede i due protagonisti, Vladimir ed Estragon, in attesa di un fantomatico datore di lavoro, il signor Godot. Della vicenda non sappiamo nient’altro, nè dove si trovino esattamente i due viandanti. Lo spettatore sa solamente che accanto a loro c’è un salice piangente, immagine simbolica che condensa in sé il tutto e il nulla. Da dove vengono i due personaggi e soprattutto da quanto aspettano? Il testo non lo dice ma soprattutto non lo sanno neanche loro stessi, i quali si trovano a rivivere le stesse situazioni, gli stessi dialoghi, gesti, all’infinito, senza poter dare risposte neppure alle domande più ovvie. Gli altri (pochi), personaggi della vicenda sono altrettanto enigmatici.
Il teatro dell’assurdo ebbe un grande sviluppo negli anni del dopoguerra e raggiunse il culmine proprio negli anni ’60 del XX secolo. Il termine teatro dell’assurdo fu coniato negli anni ’50 dallo scrittore e drammaturgo ungherese Martin Esslin (1918- 2002) per fare riferimento a un gruppo di autori teatrali europei e americani tra cui Samuel Beckett, Harold Pinter ed Eugène Ionesco, che condividevano l’idea di Albert Camus che la vita è assurda e priva di significato.
Al 1957 invece risale la prima rappresentazione di “Finale di partita“, al Royal Court Theatre di Londra. Tutti i lavori di Beckett sono estremamente innovativi e si discostano profondamente dalla forma e dagli stereotipi del dramma tradizionale, sia per quello che riguarda lo stile, sia per i temi. Sono banditi intrecci, suspense, trama e insomma tutto quello che generalmente gratifica il pubblico per concentrarsi sulla tematica della solitudine dell’uomo moderno o sul tema della cosiddetta “incomunicabilità” che blinda le coscienze degli esseri umani in un esasperato quanto inevitabile individualismo, nel senso di un’impossibilità di portare la propria insondabile coscienza “di fronte” all’Altro.
A tutte queste ricchissime tematiche si intreccia anche il motivo della perdita di Dio, del suo annientamento nichilistico ad opera della ragione e della storia, presa di coscienza antropologica che getta l’uomo in uno stato di rassegnazione e di impotenza. Lo stile del grandissimo autore è qui caratterizzato da frasi secche, scarne, plasmate sull’andamento e sulle esigenze del dialogo, spesso acre e attraversato da una fendente ironia. Descrizioni di personaggi e ambienti sono ridotti all’essenziale.
Sono caratteristiche tecniche e poetiche che non mancheranno di risvegliare l’interesse anche di parte del mondo musicale, attratto dalle numerose consonanze con le ricerche sul suono svolte fino a quel momento. Su tutti, è da segnalare il lavoro svolto su e intorno la scrittura beckettina dell’americano Morton Feldman (stimato dallo stesso Beckett).
Nel 1969 la grandezza dello scrittore irlandese viene “istituzionalizzata” attraverso l’assegnazione del premio Nobel per la letteratura, che non andò a ritirare di persona per evitare di tenere un discorso pubblico alla cerimonia della premiazione. In seguito, ha continuato a scrivere fino alla sua morte.