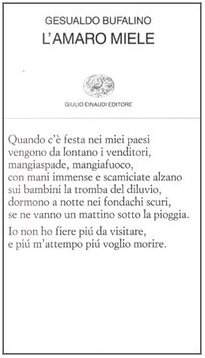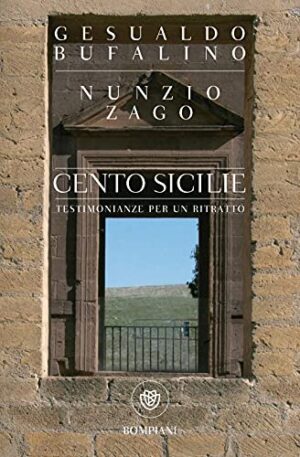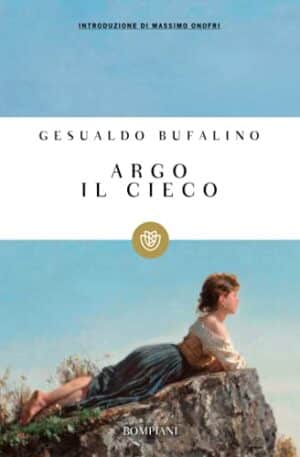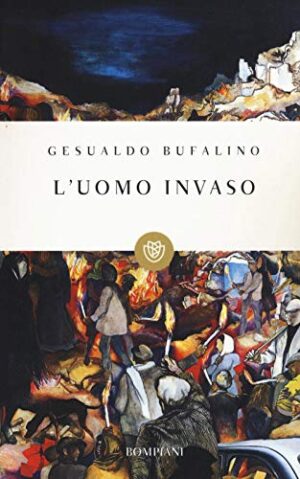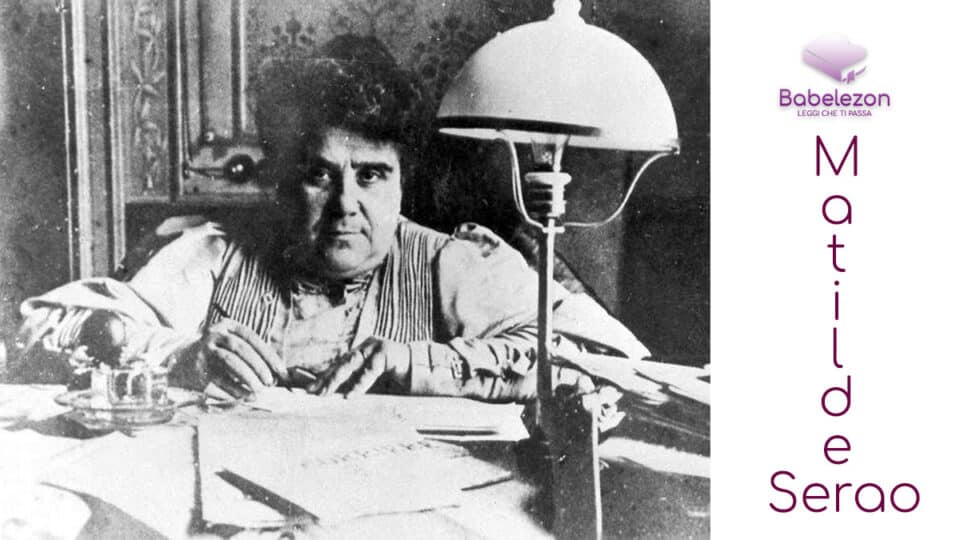La ricerca letteraria del giorno 14 giugno: Gesualdo Bufalino

La ricerca letteraria del giorno 14 giugno: Salvatore Quasimodo
14 Giugno 2024
Il mago dell’aria, Mauro Garofalo racconta Philippe Petit
14 Giugno 2024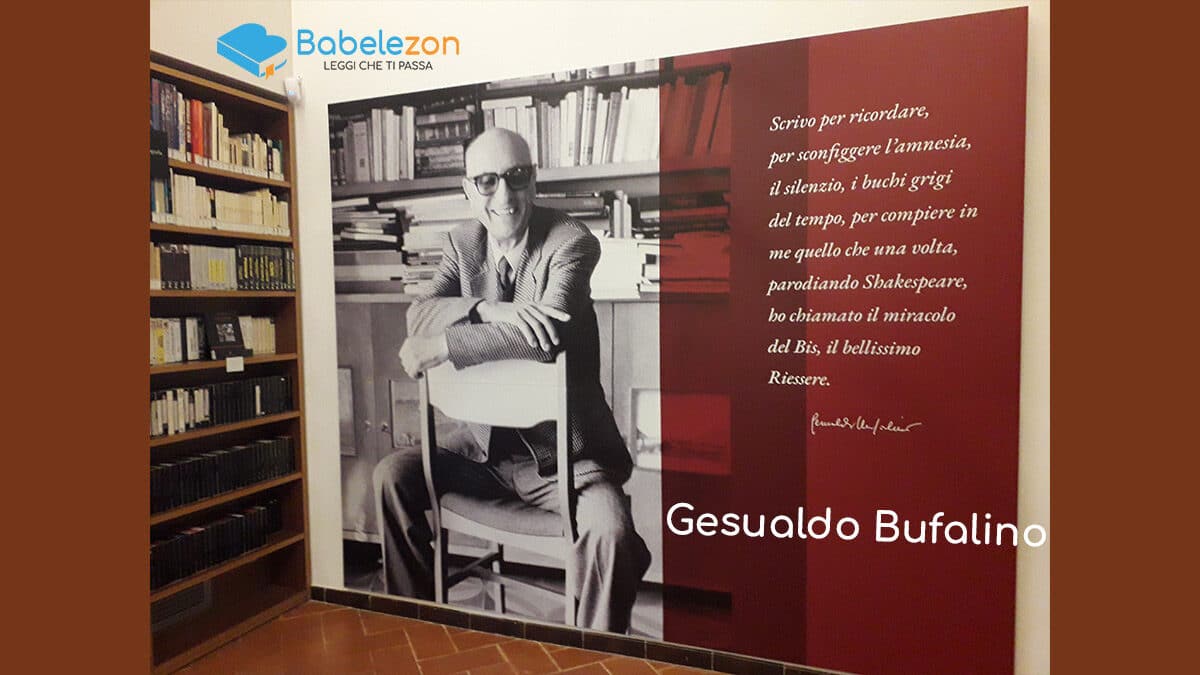
La ricerca letteraria del giorno su #babelezon
14 giugno: 🔎 Gesualdo Bufalino 📚
Muore in un incidente stradale il 14 giugno del 1996 mentre, a bordo di una “Fiat 127” guidata dal suo autista, percorreva la strada statale verso Comiso.
Gesualdo Bufalino era nato il 15 novembre del 1920 a Comiso, sperdutissimo paese nel sudest della Sicilia.
È leggenda, ma mica poi tanto, che a scoprire il talento di Gesualdo Bufalino, più che anonimo professore di Comiso (Ragusa), sia stata una scommessa. L’hanno fatta Elvira Giorgianni, la signora Sellerio, e Leonardo Sciascia, quando in casa editrice a Palermo arrivò un plico contenente lastre fotografiche di fine ‘800, appartenute a due famiglie notabili del piccolo paese in provincia di Ragusa, gli Jacono e i Meli. Le accompagnava uno scritto, un’introduzione al paese, un’esegesi della vita rurale, firmato da un professore dell’istituto Magistrale.
“Questo Bufalino ha un romanzo nel cassetto”, azzardò la signora dell’editoria. Posò la sigaretta, prese il telefono, e vinse.
Gesualdo Bufalino esordì come scrittore a sessantuno anni. Uomo di sconfinata cultura, ai limiti dell’ossessione: per ovviare alle mancanze della biblioteca del suo paese, prese a tradurre dall’italiano i testi francesi che avrebbe voluto leggere in originale, sperimentando una sorta di retroversione.
Taciturno e schivo, Dino aveva un obiettivo: realizzare una biblioteca universale, segnando con dovizia su una sua personale lista ogni nuovo acquisto aggiunto alla sua libreria. Quella collezione oggi è custodita dalla Fondazione che porta il suo nome: quasi diecimila testi, cui si aggiungono i manoscritti martoriati di correzioni e limature, riscritture a mano, a macchina e poi di nuovo a mano, i dischi – tantissimi – tutti di classica e di jazz, e i ritratti, con Sciascia, con Consolo, che gli faceva il suo amico Peppino Leone. Multimediale prima che venisse coniata la parola, il professore di Comiso allegò alla sua prima opera un’appendice esplicativa, linkando per iscritto le opere e le musiche citate nel testo.
Ricca d’un barocco mai eccessivo, mai superfluo, la prosa bufaliniana è una poesia senza versi, d’inarrivabile potenza evocativa, ricercata fino al cesello, densa di metafore e ossimori, vero vezzo dell’autore, sua inimitabile cifra stilistica. Forte d’una umbratile ironia, è l’autore stesso a rivelarsi nella pagina, in ogni aggettivo, in ogni metafora, che immancabilmente si rivela più vera del vero.
Icastico eppure esagerato, Gesualdo Bufalino era praticamente sé stesso e il suo contrario. E lo scriveva compiaciuto, nei romanzi, negli elzeviri per la stampa nazionale, e nei frammenti aforistici confluiti nelle raccolte (su tutti La luce e il lutto, L’amaro miele, Il fiele ibleo…).
“Metà di me mi detesta, e cerca alleati”: come autobiografia minima può bastare.
Il successo lo travolse senza distoglierlo da una timidezza ritrosa, quasi restìa, ai limiti del senso di colpa per essere infine venuto allo scoperto, tradendo un manoscritto cui avrebbe potuto continuare a garantire, ancora, costanti e infinite limature.
Diceria dell’untore è stato l’inizio del viaggio.
È il romanzo d’esordio, ha fatto del professore uno scrittore, è stato il caso letterario dell’anno 1981, immediato premio Campiello per un autore che debuttò nel tempo della pensione. La trama è un’autobiografia romanzata, lo stile letterario è un sontuoso barocchismo, cesellato come una cattedrale, unico, ipnotico, ricercato, esagerato: come Bufalino, si vede subito, c’è solo Bufalino.
La storia è la sua storia di sopravvissuto, sopravvissuto a una guerra mondiale in forza di una malattia mortale: autobiografia romanzata del tempo passato in sanatorio nel 1946, moribondo in attesa della fine insieme a compagni d’agonia dai quali nessuna speranza traspare, piuttosto una colpa. La colpa involontaria d’essere vivo dove tutto muore, imbelle per forza, inabile a combattere ed esonerato controvoglia: Bufalino scrittore, e Bufalino protagonista, lascia trasparire un senso di colpa del sopravvissuto.
“Un re forestiero m’era venuto ad abitare sotto le costole, un innominabile Minotauro, a cui dovevo giorno per giorno in tributo una libbra della mia vita”. La malattia come estraneo, la sopravvivenza come colpa: le storie del sanatorio della Rocca riescono a fare il paio con quelle di Se questo è un uomo di Primo Levi, per certi versi: mentre tutto muore, sopravvivere stride, sopravvivere pesa. E alla Rocca la colpa della sopravvivenza è doppia: alla guerra, prima, e alla tisi poi: “era veramente divenuto un gioco, alla Rocca, volere o disvolere morire”, c’è quest’ombra tra i protagonisti.
Diceria dell’untore svela il talento spietato del Bufalino scrittore, vivo per combinazione (“d’ordinario un pensiero mi consola: sono un uomo involontario, dunque un uomo innocente”), famoso suo malgrado.
Negli anni Ottanta, oltre agli elzeviri raccolti in Cere perse (1985) e La luce e il lutto (1988), pubblica i romanzi Argo il cieco ovvero I sogni della memoria (1984), Le menzogne della notte (1988); la raccolta di racconti L’uomo invaso (1986); ed infine Il malpensante, lunario dell’anno che fu (1987) e Saline di Sicilia (1988).
Con “Le menzogne della notte” il capolavoro bufaliniano, guadagnò lo Strega nell’anno della sua uscita 1988. Un giallo metafisico, raffinatissimo e non dichiarato: che ci sia un mistero da risolvere si capisce strada facendo, e quali siano le menzogne del titolo non lo svela che l’ultima pagina. Quattro i protagonisti, un deus ex machina mai visto e sempre temuto, una figura divina, forse il destino, forse Domineiddio, che non visto dà le carte.
Ancora una volta condannati a morte, come nel romanzo d’esordio, condannati a morte rinchiusi in una prigione borbonica, quattro personaggi raccontano le vite, i crimini e le ingiustizie fatte e subìte. Quattro storie credibili e vere, o forse del tutto inventate per giustificare un’innocenza presunta.
La padronanza della lingua qui è sfacciata, inarrivabile: vi sfidiamo a indovinare quale azione meschina e adolescenziale guadagni una descrizione come “tentativo di guarirsi per un attimo del crepacuore di non essere Dio”. Ed è tutto un rimando, questa perla di libro, a partire dall’esergo, che forse è una dedica, forse una sfida: sempre alla vita, o sempre alla morte: “a noi due”.
Nel 1990 escono Calende greche e Saldi d’autunno, a cui seguono nel 1991 i volumi Qui pro quo, Il Guerrin Meschino e Rondo della felicità. Nel 1992 viene edito il libro fotografico Il tempo in posa. Immagini di una Sicilia perduta.
Infine, negli ultimi anni di vita vengono pubblicati Bluff di parole (1994), Il fiele ibleo, I languori e le furie (1995), e Tommaso e il fotografo cieco ovvero il patatràc (1996).