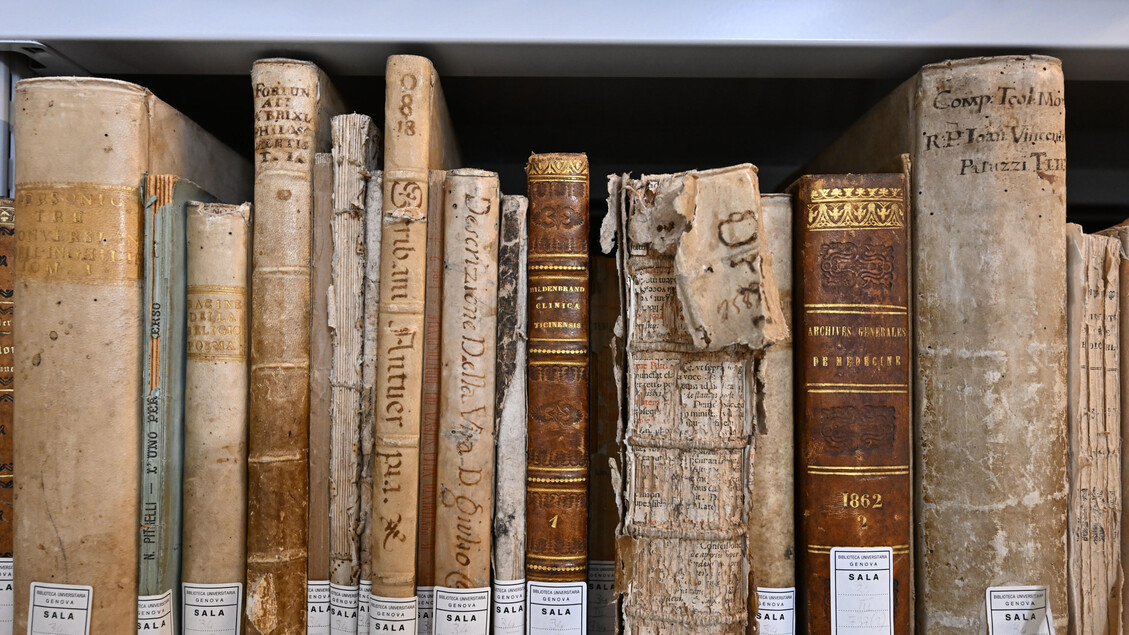(di Marzia Apice) DONATA COLUMBRO, PERCHE’ CONTARE I FEMMINICIDI E’ UN ATTO POLITICO (Feltrinelli, pp.208, euro 18).
Lasciare un segno per ogni vita persa e raccontare storie di dolore, abuso e sopraffazione utilizzando insieme le parole e i numeri, perché “nominare” e “misurare” sono le azioni indispensabili per provare a contrastare la violenza di genere.
A spiegarlo, con una approfondita e lucida analisi, è Donata Columbro, autrice per Feltrinelli del saggio “Perché contare i femminicidi è un atto politico”.
La riflessione inizia da una constatazione: non esiste una neutralità statistica, i numeri cioè sono frutto di una scelta precisa, e quindi, di dinamiche di potere. In un fenomeno complesso come quello dei femminicidi, e della violenza di genere, capire “cosa” contare e “come” classificare i dati è essenziale. In Italia per esempio non esiste un registro ufficiale dei femminicidi, non ci sono cioè dati facilmente consultabili e accessibili a tutti, e le statistiche legate alla violenza degli uomini sulle donne spesso vengono inglobate in misurazioni più generali. Eppure, spiega Columbro, “il femminicidio non è un fatto privato, ma l’espressione di una violenza e di un abuso di potere sostenuto dalla struttura patriarcale delle istituzioni e di una cultura che vede l’egemonia maschile come normale, statisticamente e socialmente”. La violenza (fisica, ma anche psicologica ed economica) e la disuguaglianza tra i sessi si riconoscono anche dai numeri, se però organizzati in modo chiaro e sistematico. Ed ecco perché, a fronte di una carenza di chiarezza statistica da parte delle istituzioni, il lavoro di raccolta portato avanti tra mille difficoltà dalle associazioni femministe, molto radicate nei territori e a contatto con le famiglie delle vittime o con le “sopravvissute”, assume una valenza cruciale: i loro “contro dati” allargano l’orizzonte dell’analisi, facendo emergere con i numeri similitudini e differenze e quindi aggiungendo dettagli utili alla comprensione di un fenomeno che va letto nella sua globalità. Dai dati per esempio capiamo che la violenza non conosce distinzioni geografiche, o di età e classe sociale, e soprattutto che non esiste “normalità” che tenga: a colpire infatti non sono soltanto uomini che vivono in condizioni di degrado o ai margini della società, ma spesso sono proprio i nostri “bravi ragazzi”, i partner (o ex partner), i familiari, le persone più vicine. E le vittime, chi sono? Potenzialmente tutte le donne, spiega l’autrice, che nel libro ha raccontato non solo cosa accade in Italia ma anche il contesto internazionale: in carriera o disoccupate, di qualsiasi nazionalità e grado di istruzione, dalle studentesse alle sex workers, dalle persone transessuali a quelle disabili fino alle madri di famiglia, non ci sono donne escluse, perché il tema qui è il possesso, il voler impedire l’emancipazione, il non accettare la libera scelta della donna, il ricatto economico.
“Contare, misurare e rendere pubblici i dati in modo disaggregato” quindi, ci dice la giornalista, divulgatrice e scrittrice, è un “atto politico” per estirpare le radici della cultura del patriarcato dalla nostra società: un’opportunità che può servire soprattutto ai decisori politici, utile per capire quali azioni mirate adottare, in termini di fondi (per offrire un posto sicuro a chi scappa o per rispondere ai bisogni di chi sopravvive o dei familiari che restano), convenzioni da fare, divulgazione culturale (nelle scuole, per esempio).